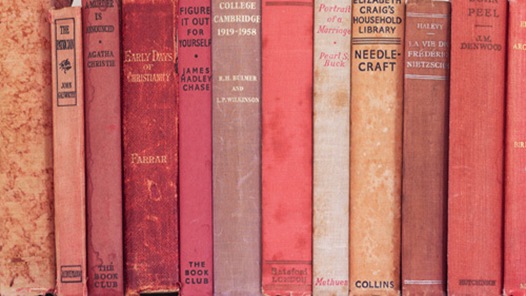Quella mattina partii dalla Centrale sotto un cielo livido come questo, che andava spaccandosi nell’alba di aprile. Il verde nuovo delle foglie ornava i rami del paesaggio che scorreva dietro i finestrini. Avevo due compagni, ci eravamo riconosciuti subito “sulla stessa barca”, capelli corti e borsone: “Militare? A Merano?”. A Brescia dovemmo lasciare il posto a chi lo aveva prenotato, rimanemmo in corridoio con il borsone tra i piedi fino a Bolzano, fino al cambio di treno, mentre il mondo strisciava oltre i vetri sporchi dell’Intercity.
A Bolzano salimmo su un vecchio elettrotreno marrone, quello derivato dalla “littorina”: ci portò a Merano tra i campi di mele in fiore, nuvole bianche intersecavano i binari e lo scorrere scintillante dell’Adige. La città infine si profilò con il suo ippodromo e le sue case Liberty: scendemmo alla stazione centrale e non a Maia Bassa, come avremmo dovuto. Comunque, anche lì c’erano ad attenderci i camion militari e i caporali istruttori; ci fecero salire sui cassoni e scendemmo verso le caserme - sentivo l’aria attraversare il telone, guardavo la città scorrere veloce dall’apertura posteriore.
Quando attraversammo la sbarra bianca e rossa del passo carraio della “Rossi”: sentii come se la mia libertà se ne andasse via davvero in quel momento. Era mezzogiorno ormai e ci portarono subito alla mensa. C’era della pasta e una cotoletta, non c’erano più bibite, solo acqua. Per la prima volta venimmo schierati in fila e camminammo fino al cinema; ci lasciarono lì nel piazzale ad attendere. Ero ancora con i due compagni del treno, discorrevamo sotto i grandi tigli dalle tenere foglie. Era un modo per vincere l’ansia dell’ignoto, e intanto conoscevamo altri ragazzi, fraternizzavamo. Vennero alcuni caporali e ci divisero per distretto di appartenenza: Como, Varese, Milano, Bergamo, Brescia, Bolzano, Vari. La Valtellina quell’anno non c’era, esentata dalla leva per l’alluvione del luglio precedente. Lì persi i due amici del treno, che venivano dal distretto di Milano. Io fui indirizzato verso il gruppo di Como.
Finalmente ci fecero entrare: dovemmo attendere ancora che il nostro nome fosse chiamato. Le ore passavano lente e inesorabili, una cosa a cui mi sarei abituato in fretta, almeno per quel mese di C.A.R.; vennero le sei e ritornammo in mensa e poi di nuovo al cinema. Mi chiamarono. Si doveva stare a distanza di uno sgabello dalla lunga schiera di tavoli – un accenno della disciplina cui tutti ci saremmo dovuti adeguare, anche quel ragazzo di Sotto il Monte che aveva capelli da rockstar heavy metal. I tavoli andavano passati uno per uno: qui declinare le generalità, là lasciare le impronte digitali, altrove ritirare uno scontrino oppure spiegare le proprie attitudini. Infine un militare visibilmente annoiato mi assegnò alla 50ª Compagnia e mi definì “Alpino verde” grazie a un bigliettino con tale dicitura timbrata, che mi consigliò di non perdere.
Presi il mio borsone e mi avviai con altri ragazzi alle visite mediche. Dopo un’altra lunga attesa ci fecero un’iniezione nel braccio e il Tine Test, ci pesarono e misurarono l’altezza. Ci indirizzarono infine alla palazzina che, entrando dalla caserma, si trovava sul lato destro, la “Venini”: era quella la 50ª Compagnia. Nell’atrio c’era il disegno di un’aquila e dipinta sul muro la Preghiera dell’Alpino: “Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai”, avrei avuto modo in una lunga sera di piantone di impararla a memoria. Salimmo le scale e un caporale in tuta azzurra dell’Esercito ci accolse in una saletta e ci fece compilare un test-questionario, quindi ci avviò al magazzino di compagnia a ritirare materasso, lenzuola, cuscino, coperta e zainetto.
Finalmente fui incorporato nel plotone: 50ª Compagnia, II° Plotone, IVª squadra. Arrivai carico come un mulo e un altro caporale mi chiese come mi chiamassi. Gli risposi e mi mandò nella quarta camerata. Cercai il mio letto nelle camerate contrassegnate dal 4: a destra non c’era, lo trovai a sinistra. Era la branda superiore del castello. Vi adagiai il materasso, infilai le lenzuola e la coperta: era il primo letto che facevo in vita mia, ma da quel giorno non avrei più smesso. Infilai il cuscino nella federa e il gioco era fatto. Era tardissimo, ero sfinito, ma avevo ancora una cosa importante da fare.
Nel 1988 non c’erano ancora i cellulari, ci si affidava al magico gettone scanalato o in alternativa alle monete da 200 lire. Anche le schede telefoniche erano ai loro albori. Chiesi al caporale - si chiamava Pessina ed era varesino - se potessi uscire a telefonare; mi indicò le cabine della caserma, a destra del passo carraio e mi esortò a fare in fretta. Chiamai casa: erano quasi le 22, ormai. Ed era giunto il momento di prepararsi per la notte.
Mi recai nei bagni con molto timore di quello che vi avrei trovato. Invece erano moderni ed efficienti, pavimentati con piastrelline di cotto rosso. Ero in pigiama ormai, stavo per andare in branda quando scattò il contrappello. Fecero i nomi e tutti rispondemmo “Presente”, anche il ragazzo che dormiva nella branda sotto la mia e che avevo fatto di tutto per non svegliare: “Ritsch” era il nome che avevo letto sulla targhetta e che il caporale Corbetta, varesino, aveva chiamato. Poi chiamò me… “Presente!”